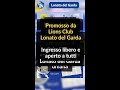Le 14 stazioni della Via Lucis resteranno esposte fino al 28 febbraio nella Sala dei Provveditori del Palazzo municipale, visitabili il sabato e la domenica. Il percorso in 14 stazioni, ideato in occasione del Giubileo del Duemila, rinnovando la tradizione, che fu viva soprattutto dal tardo ’500 al ’700, dei Sacri Monti, era stato pensato per una collocazione da Salò a Serniga. Ma sono nate polemiche e perplessità nella stessa Giunta, perché le 14 formelle affidate ad altri artisti sarebbero finite in santelle lungo un percorso poco battuto a piedi, a rischio di vandalismi. Probabilmente le piazzeranno in pieno centro, in via Gasparo da Salò, e sul percorso per Serniga andranno dei fotocalchi. Le santelle, anziché la più consueta Via Crucis lungo le stazioni della Passione, evocano gli eventi che la liturgia colloca tra la Pasqua e la Pentecoste, del Cristo che si rivela ai discepoli, per comunicare la Resurrezione. Il Cristo che indica al credente la via del ritorno dell’umanità a Dio. Non essendo stato qui il committente un istituto religioso, ma l’Amministrazione civica, ci si domanda quale significato possa acquistare il percorso per tutta la comunità, credenti e non credenti. Lo si ritrova senz’altro nel richiamo alla pratica dell’arte come legante di un contesto fisico e spirituale. Nell’Europa occidentale si impose la figura del Cristo crocifisso, uomo sofferente e morente che rivela il volto divino; nell’Europa orientale quella del Cristo abbagliante di luce e di gloria. Proprio fondendo le due tradizioni si arriva alla Via Lucis salodiana. Dalla via che passa attraverso la sopportazione della morte, all’invito a fare esperienza della bellezza ed a irradiarla, ripercorrendo le tappe della Trasfigurazione.
Le opere e il loro significato
Vediamo le 14 «stazioni». In quella di Ilmì Kasemi, Gesù risorge dalla morte: fonde compostezza e sconvolgimento emotivo. Nella formella di Entela Kasémi, i discepoli trovano il sepolcro vuoto. Insegue mezzi scabri e laconici, in nome dell’energia costruttiva. Nella formella di Ugo Donati, il Risorto si manifesta alla Maddalena: il disegno delle figure, fatto arabesco, è assorbito totalmente nella luce, per attingere una dimensione ultrasensibile. Nella formella di Giuseppe Rivadossi si incontra il Risorto sulla strada per Emmaus. Le figure sprigionano dal grembo della santella, serrate nel sentimento corale dell’esistenza, nei secoli. In Albano Morandi, il Risorto spezza e dona il pane. Un segno di croce frantuma la formella come un guizzo di luce, tra ferita e grido, dentro una voragine.
In Franca Ghitti, il Risorto si manifesta ai discepoli. La santella nasce da scarti di stampi in ferro di antiche fucine: in uno specifico ambiente, si fondono la vita delle forme e quella degli uomini, acquistando consapevolezza che la vita umana non si esaurisce nel tragitto di una sola esistenza. Nella formella di Mariano Fuga, il Risorto dà il potere di rimettere i peccati. L’amore spande i suoi doni, e qui l’alito divino anima una sapida, vivida gestualità. La formella di Antonio Stagnoli è dedicata al Risorto che conferma la fede di Tommaso. Il miracolo scaturisce con naturalezza, dalla realtà quotidiana, come risarcimento di solidale pietà agli umiliati e offesi, che scontano su di sè il dolore del mondo. Gianfranco Renzini sceglie il Risorto che si manifesta sul lago di Tiberiade. La storia sacra si compie alla trascrizione lirica e stupefatta della realtà minima dei pescatori intenti a tirare le reti, poveri di spirito degni delle beatitudini evangeliche.
In Giuseppe De Lucia, il Risorto conferisce il primato a Pietro. Un tono quieto e persuasivo, nel porre l’accento su dati reali, riconoscibili, il Cristo come un padre buono e consolatore. Per Paolo Frascati, il Risorto che invia i discepoli nel mondo è un fremito d’energia, una fiamma guizzante che dalla notte più cupa del mondo in cui si dibatte in Croce, trasforma l’invocazione, il lamento, il grido in un’ansia di resurrezione nella luminosità. Nell’opera di Giulio Mottinelli, il Risorto ascende al Cielo, laddove la luce, come una cascata che ridesti tutta la natura in un sogno di rigoglio, penetrando nei pori più segreti delle cose, illumina un tempo estatico.
Nella formella di Beatriz Millar ci si attesta con Maria in attesa dello Spirito Santo: l’umanità contemporanea fruttifica sull’albero della vita, o albero-Chiesa, che si s’identifica anche con un rosone. Un racconto di colori simbolici della fede come comunicazione fraterna. Nell’ultima stazione, Attilio Forgioli figura il Risorto che manda lo Spirito Santo con una manipolazione plastica, barocca e organicista della ceramica: la luce divina irraggia la terra che è un coagulo denso e palpitante di colori gemmati, fosforescenti. Le mani fantasticano quando parlano con la materia, cercano di liberare lo spirito che vi è imprigionato. Questo, comunque, dice a tutti la Via Lucis di Salò. f. lor.


 Iscriviti al nostro canale Telegram per tutti gli ultimi aggiornamenti
Iscriviti al nostro canale Telegram per tutti gli ultimi aggiornamenti
 Garda Flash News: notizie lampo, stile essenziale
Garda Flash News: notizie lampo, stile essenziale